Santo Padre GREGORIO PALAMAS
Vescovo di Tessalonica, il Taumaturgo
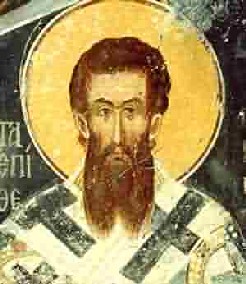
|
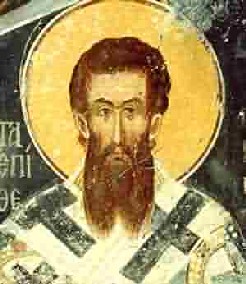 |
Il
nostro santo padre Gregorio nacque a Costantinopoli nel 1926.
I suoi genitori, aristocratici emigrati dall'Asia Minore durante l'invasione
turca, facevano parte della corte dell'imperatore
Andronico II Paleologo ( 1282/1328).
Malgrado le alte funzioni, suo padre aveva una intensa vita di preghiera e,
sedendo in senato, arrivava a non ascoltare
l'imperatore che si rivolgeva a lui, tanto era immerso nella preghiera.
Egli morì allorché Gregorio era ancora giovane, dopo aver rivestito
l'abito monastico.
Sua moglie desiderava anch'essa prendere il velo ma ritardò qualche tempo
per garantire l'educazione ai suoi sette figli.
Il primogenito, Gregorio, fu affidato ai migliori maestri delle scienze profane
e acquistò, tempo qualche anno, una perfetta padronanza dei ragionamenti
filosofici: a tal punto che il suo maestro credeva, ascoltandolo, di sentire
lo stesso Aristotele in persona.
Malgrado questi successi
intellettuali, il giovane dirigeva la sua verità interiore solo verso
le cose di Dio.
Egli frequentava i monaci più stimati della capitale e aveva scelto come
padre spirituale Teolepto di Filadelfia (1250/1325) che lo iniziò alla
santa sobrietà* e alla preghiera del cuore.
Verso il 1316, Gregorio decide di abbandonare le vanità del mondo, e
trascina con lui verso la vita monastica sua madre, due sorelle, due fratelli
ed un ;!': gran numero di servitori.
Essendosi recati a piedi sulla Santa Montagna dell'Athos, Gregorio e i suoi
due fratelli si stabilirono nelle vicinanze del monastero di Vatopedi, sotto
la direzione di un anziano proveniente dai Monte S. Ausenzio
Nicodemo.
Esercitato fin dall'infanzia alla pratica delle virtù fondamentali che
sono l'obbedienza, l'umiltà, la dolcezza, il digiuno, la veglia e le
varie austerità che permettono di sottomettere il corpo allo spirito,
il giovane fece rapidi progressi nella santa attività della preghiera.
Giorno e notte, si rivolgeva
senza sosta a Dio dicendo con singhiozzi: «Illumina le mie tenebre».
Dopo qualche tempo, la Madre di Dio, che egli aveva come confidente fin dalla
giovinezza, gli inviò S.Giovanni il Teologo per promettergli la Sua protezione
in questa vita e nell'altra.
Ora, dopo solamente tre anni, la morte prematura di suo fratello Teodosio, ben
presto seguita da quella di Nicodemo, spinge Gregorio e l'altro fratello Macario,
a congiungersi alMonastero di Grande Lavra.
Nominato cantore, Gregorio riscuoteva l'ammirazione dei suoi compagni, per lo
zelo nella pratica simultanea di tutte le sante virtù evangeliche.
Egli conduceva una vita così austera che sembrava essersi liberato dal
peso del corpo: poteva restare anche mesi senza prendere mai sonno. Perfetta
nella vita comune, la sua anima era però desiderosa delle dolcezze della
solitudine; è perciò che egli si ritirò, nel giro di tre
anni, nell'eremitaggio di Glossia, sotto la direzione di un monaco eminente
chiamato Gregorio di Bisanzio.
Dalla purificazione delle passioni egli potè elevarsi con la preghiera
verso la contemplazione dei misteri della creazione.
Grazie alla solitudine e
alla quiete inferiore (esichia) Gregorio manteneva tutto il tempo la mente dal
profondo del cuore, al fine di invocarvi il Signore Gesù Cristo con compunzione,
di maniera che egli diveniva tutto intero preghiera, e dolci lacrime colavano
continuamente dai suoi occhi come da due fontane.
Ma, le razzie incessanti dei pirati turchi costrinsero ben presto Gregorio e
i suoi compagni ad abbandonare la loro residenza.
Con dodici monaci, il Santo decide di andare a venerare i luoghi Santi e di
trovare rifugio al Monte Sinai, ma fu impedito di realizzare questo progetto
e restò qualche tempo a Tessalonica, dove partecipò alle attività
di un circolo spirituale, spinto dal futuro patriarca Isidoro, che si sforzava
di diffondere la pratica della preghiera di Gesù presso i suoi fedeli,
facendo loro approfittare delle esperienze dei monaci.
Nel 1326 fu ordinato prete, dopo aver ricevuto la visione che questa era la
volontà di Dio.
Egli, partì poi per fondare un eremitaggio nei dintorni di Veria, dove
per ben cinque anni si dedicò ad una ascesi ancora più rigorosa.
Egli restava isolato cinque
giorni e settimane nel digiuno, veglia e preghiera bagnata di lacrime, ricompariva
il sabato e la domenica per celebrare la divina liturgia, dividendo un pasto
fraterno e intrattenendosi su qualche argomento spirituale con i suoi compagni
di ascesi.
Egli continuava così ad elevarsi nella contemplazione e ad entrare in
unione diretta con Dio nel suo cuore.
Alla morte di sua madre, andò a Costantinopoli e prese sua sorella che
installò in un eremitaggio vicino al suo.
Ma non potè trovare a lungo riposo, perché la regione era regolarmente
devastata dalle incursioni dei Serbi.
Decide quindi di ritornare all'Athos e si stabilisce nell'eremitaggio di San
Saba, un po' al di sopra di Lavra.
Questo nuovo soggiorno fu per lui l'occasione di isolarsi dagli uomini per conversare
solo con Dio.
Egli non andava che eccezionalmente al Monastero e non comunicava con i suoi
rari visitatori che la domenica e i giorni di festa.
E fu così che dalla
contemplazione ancora esteriore, Gregorio pervenne alla visione di Dio nella
luce dello Spirito Santo e alla deificazione promessa da Cristo ai suoi discepoli
perfetti.
Un giorno, in sogno, vide che era ripieno di un latte venuto dal cielo, il quale
uscendo da lui si trasformava in vino riempiendo l'atmosfera circostante di
un sublime aroma.
Era quello il segno che gli rivelava che il tempo era ormai arrivato di insegnare
ai suoi fratelli i misteri che Dio gli rivelava.
Egli redasse allora qualche scritto ascetico, poi fu nominato igumeno del monastero
di Esfìgmenou (1335).
Ma il suo zelo e le sue esigenze spirituali non furono comprese dai duecento
monaci che lì vivevano, cosicchè dopo un anno egli ritornò
nel suo eremitaggio.
A quell'epoca un monaco originario della Calabria, Barlaam, si era acquistato
una brillante rinomanza tra i migliori intellettuali della capitale, grazie
alla sua abilità e speculazioni filosofiche.
Egli amava particolarmente commentare gli scritti mistici di S. Dionisio l'Aereopagita
ma ne dava una interpretazione puramente filosofica, facendo della conoscenza
di Dio, l'oggetto di freddi ragionamenti e non d'esperienza.
Avendo fatto la conoscenza di semplici monaci, questo delicato umanista era
rimasto scandalizzato dai loro metodi di preghiera e dello spazio che essi lasciavano
all'elemento sensibile nella vita spirituale. Egli colse questa occasione per
calunniare i monaci e accusarli di eresia.
Gli esicasti fecero allora
appello a Gregorio che redasse più trattati polemici, nei quali rispondeva
alle accuse di Barlaam situando la spiritualità monastica in una vasta
sintesi dogmatica.
Egli dimostrava che l'ascesi e la preghiera sono il risultato di tutto il mistero
della Redenzione e sono il modo per ognuno di fare sbocciare la grazia depositata
in ciascuno al S. Battesimo.
Egli difendeva cosi le buone fondamenta dei metodi utilizzati dagli esicasti
per fissare la mente nel cuore: perché, dopo l'Incarnazione, è
nei nostri corpi santificati dai sacramenti e innestati dalla Eucaristia al
corpo di Cristo che dobbiamo ricercare la grazia dello Spirito. Questa grazia
è la gloria di Dio essa stessa che, rifulgendo dal corpo di Cristo il
giorno della Trasfigurazione ha colpito i discepoli di stupore (cf. Matteo 17)
e che, risplendendo adesso nel cuore purificato dalle sue passioni, ci unisce
veramente a Dio, ci illumina, ci deifica e ci dona un assaggio della gloria
che brillerà così sul corpo dei Santi dopo la Resurrezione generale.
Affermando cosi la piena realtà della deificazione, Gregorio non negava
pertanto che Dio sia assolutamente trascendente e inconoscibile nella Sua essenza.
Al seguito dei Santi Padri,
ma in maniera più netta, egli distingueva in Dio l'essenza impartecipabile
e le energie eterne, creatrici e provvidenziali, attraverso le quali il Signore
faceva partecipare gli esseri creati, al Suo essere, alla Sua vita e alla Sua
luce, senza tuttavia introdurre alcuna divisione nella unità della natura
divina.
Per S.Gregorio, Dio non è dunque il concetto dei filosofi, ma Egli è
Amore, Persona vivente e «fuoco divorante» come insegna la Scrittura,
che fa tutto per deificarci.
Immediatamente riconosciuto dalle autorità dell'Athos nel Tomo Aghioritico,
le abbaglianti argomentazioni del Santo furono adottate dalla Chiesa che condannò
Barlaam, e con lui l'Umanesimo filosofico che doveva ben presto animare il Rinascimento
europeo, nel corso di due concili riunitisi in Santa Sofia nel 1341.
Barlaam venne condannato e trovò rifugio in Italia, ma la controversia
non era comunque conclusa.
Gregorio, che per redigere
i suoi trattati, aveva vissuto qualche tempo recluso in una casa di Tessalonica,
aveva appena avuto il tempo di raggiungere il suo eremitaggio all'Athos, che
uno dei suoi vecchi amici, Akindinos, riprese l'essenziale degli argomenti del
Calabrese, accusando Gregorio di introdurre delle novità nella distinzione
tra essenza ed energie.
Arbitro tra Barlaam e Gregorio, Akindinos era uno di quei conservatori formalisti
che si accontentavano della ripetizione di semplici formule per condannare gli
umanisti, senza cercare di penetrare lo spirito della tradizione.
Fu allora che scoppiò una terribile guerra civile dovuta alla rivalità
tra il Granduca Alessio Apokankos e l'ambizioso Giovanni Cantacuzeno, amico
di Palamas.
Il patriarca Giovanni Kalecas prese le parti di Apokankos e, attraverso l'intermediazione
di Akindinos, intentò a Gregorio un processo, in seguito al quale venne
scomunicato il Santo e condannato alla prigionia.
Durante i quattro anni della sua reclusione, Gregorio non abbandonò la
sua attività: egli intrattenne una vasta corrispondenza e redasse un
importante trattato contro Akindinos.
Verso il 1346, quando il
vantaggio passò a Cantacuzeno, la reggente Anna di Savoia prese le difese
del Santo e fece deporre il patriarca la notte stessa dell'entrata trionfale
di Cantacuzeno nella capitale.
Costei nominò Isidoro patriarca (1347/1350) e riunì un nuovo concilio
per giustificare gli esicasti.
La controversia non trovò tuttavia un esito definitivo che nel 1351,
dopo la riunione di un terzo concilio contro l'umanista Niceforo Gregoras. Nel
Tomo Sinodale, la dottrina di San Gregorio sulle energie increate e sulla natura
della Grazia, veniva riconosciuta come regola di fede per la Chiesa Ortodossa.
Isidoro procedette alla nomina di una serie di nuovi vescovi e affidò
a Gregorio il seggio di Tessalonica (marzo 1347).
Ma poiché la città era nelle mani della parte zelota avversaria
di Cantacuzeno, il nuovo metropolita non potè prendere possesso del suo
seggio.
Gregorio allora si rifugiò qualche tempo a Limnos, dove mostrò
un comportamento eroico durante una epidemia e potè infine rientrare
in città dove venne acclamato come Cristo trionfante negli inni di Pasqua.
Nelle sue numerose attività
pastorali fece guadagnare ai suoi fedeli la grazia abbondante che aveva conquistato
nella solitudine.
Egli fece brillare sulla città la luce che illuminava il suo cuore e
dispensò con abbondanza i suoi insegnamenti ispirati, insistendo sul
legame stretto che deve unire la preghiera e la via sacramentale nella vita
di ciascun cristiano.
Per la potenza di Cristo egli compì numerosi miracoli e guarigioni.
Nel corso di un viaggio verso Bisanzio, cadde nelle mani dei Turchi e fu messo
in prigione in Asia Minore per un anno.
La relativa libertà di cui disponeva e la sua apertura di spirito, gli
permisero di intrattenere discussioni teologiche amichevoli con teologi musulmani
e con il figlio dell'Emiro Orkam.
Liberato grazie ad un riscatto venuto dalla Serbia, riguadagnò Tessalonica
dove proseguì la sua opera di pastore e taumaturgo.
Egli cadde gravemente ammalato ma qualche tempo prima della sua morte, vide
S.Giovanni Crisostomo apparirgli per invitarlo a raggiungerlo in mezzo al coro
dei Santi gerarchi, il giorno in cui la loro festa sarebbe stata celebrata.
Fu così infatti che
il 14 Novembre 1359, il Santo rimise la sua anima a Dio.
Allorchè spirò, il suo viso irradiò una luce simile a quella
che brillò su S. Stefano (Atti 6.7).
Dio mostrò così, la verità della sua dottrina sulla realtà
della deificazione attraverso la luce increata del Santo Spirito.
S. Gregorio fu canonizzato nel 1368, e per i suoi numerosi miracoli fu considerato
fino ad oggi come il secondo protettore di Tessalonica dopo S. Demetrio.
Apolitikio:
NOTIZIE
*La festa di S.Gregorio è solennemente festeggiata la seconda Domenica di Quaresima, dopo la festa dell'Ortodossia.
*La sobrietà è la vigilanza su quei movimenti della parte passionale dell'anima che mettono l'intelleto in cammino di purificazione.